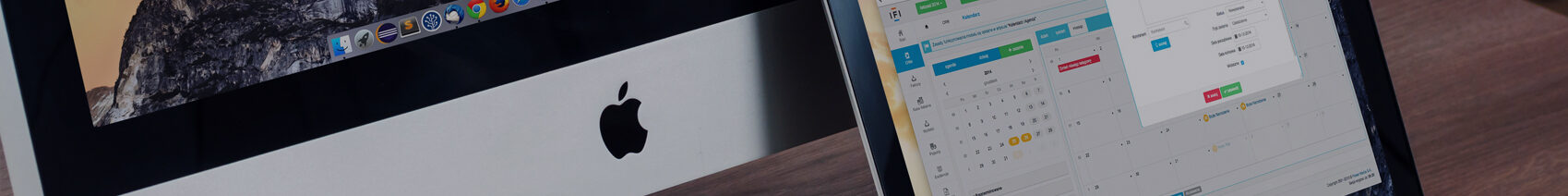L’appello è arrivato: “Non condividete quelle immagini e quei video di morte, non diffondete notizie non verificate”. Sembra una cosa ovvia, ma in verità diventa centrale, quasi ossessivo, chiedersi se pubblicare o meno, quando il terrorismo colpisce una società altamente mediatizzata. E dove finisce il limite della testimonianza per lasciare spazio a quello dell’involontaria propaganda nera? Ciò che fino a pochi anni fa era un dramma quasi del tutto giornalistico precipita ora nelle mani di qualsiasi involontario testimone. Dall’hashtag #PortesOuvertesNice, per offrire rifugio e sostegno alle migliaia di persone scaraventate nel panico del lungomare, a #RechercheNice, per condividere notizie di amici e parenti dispersi, in cinguettii che rilanciano foto e nomi di persone da contattare. Senza contare la circolazione delle informazioni di soccorso. O l’ormai (troppo) frequente strumento attivato da Facebook, il Safety Check. Come dire che le piattaforme sociali sono ormai un incrocio fra il vecchio centralino d’emergenza e le unità di crisi di Polizia e ministeri: una formidabile risorsa di notizie, rassicurazioni, contatti. Assai avvelenata, è vero, ma in ogni caso a disposizione. Cambiando totalmente fronte e contesto, basti vedere l’uso della posizione di WhatsApp per velocizzare gli interventi nell’incidente ferroviario pugliese del 12 luglio. In quel veleno digitale, oltre alle immancabili bufale, finiscono nelle prime ore successive a questi eventi scatti e clip sui quali appunto non si smette d’interrogarsi. Proprio sulle stesse piattaforme in cui, a pochi clic di distanza, altri account pubblicano stomachevoli manifestazioni di giubilo per l’ultima carneficina. Ciò che, pur essendo di una chiarezza cristallina, tanto chiaro non appare è il concetto per il quale sono gli utenti a plasmare il modo in cui i social media sono utilizzati e si evolvono, e non il contrario. I social media sono più che comunicazione: sono anche un posto in cui viviamo: hanno certamente le loro peculiarità, ma allo stesso modo della ‘vita di ufficio’ in contrapposizione alla ‘vita privata’: non diremmo mai che la prima non è ‘vita vera’. Pertanto, anche se ci sono delle differenze, dovremmo smettere di pensare che l’online sia meno vero che l’offline. Stiamo vivendo la storia, una storia in cui la guerra si combatte sulla Rete prima che sulla strada. E questo lo ha sottolineato nientemeno che l’esercito britannico, creatore di un’unità speciale per quella che lo Stato Maggiore britannico ha definito come “Guerra Non Letale”. Una guerra che non si svolge sul campo di battaglia, ma sui social network. La 77esima brigata sarà formata da 1500 uomini esperti in operazioni psicologiche che verranno sviluppate utilizzando proprio i social network per minare la resistenza del nemico. In Inghilterra i soldati della brigata sono già stati ribattezzati, non senza nascondere un pizzico d’ironia, Facebook Warriors. Curiosamente, la nuova forza dell’esercito inglese eredita il numero di brigata che è appartenuto a un gruppo di combattenti che ha fatto la storia della Seconda Guerra Mondiale: i Chindits che affrontarono i giapponesi sull’isola di Burma. Minori in numero rispetto agli avversari nipponici, svilupparono una tattica volta a creare insicurezza e a colpire il morale del nemico con continui attacchi in puro stile guerriglia. Un po’ quello che ci si aspetta dall’unità recentemente creata, in una guerra condotta a colpi di tweet e post pubblicati sui profili Facebook, con tanto di foto. Anche se può sembrare un’idea bizzarra, i social network vengono già usati con scopi bellici, ancor prima che venisse creata un’unità dedicata allo scopo.
L’appello è arrivato: “Non condividete quelle immagini e quei video di morte, non diffondete notizie non verificate”. Sembra una cosa ovvia, ma in verità diventa centrale, quasi ossessivo, chiedersi se pubblicare o meno, quando il terrorismo colpisce una società altamente mediatizzata. E dove finisce il limite della testimonianza per lasciare spazio a quello dell’involontaria propaganda nera? Ciò che fino a pochi anni fa era un dramma quasi del tutto giornalistico precipita ora nelle mani di qualsiasi involontario testimone. Dall’hashtag #PortesOuvertesNice, per offrire rifugio e sostegno alle migliaia di persone scaraventate nel panico del lungomare, a #RechercheNice, per condividere notizie di amici e parenti dispersi, in cinguettii che rilanciano foto e nomi di persone da contattare. Senza contare la circolazione delle informazioni di soccorso. O l’ormai (troppo) frequente strumento attivato da Facebook, il Safety Check. Come dire che le piattaforme sociali sono ormai un incrocio fra il vecchio centralino d’emergenza e le unità di crisi di Polizia e ministeri: una formidabile risorsa di notizie, rassicurazioni, contatti. Assai avvelenata, è vero, ma in ogni caso a disposizione. Cambiando totalmente fronte e contesto, basti vedere l’uso della posizione di WhatsApp per velocizzare gli interventi nell’incidente ferroviario pugliese del 12 luglio. In quel veleno digitale, oltre alle immancabili bufale, finiscono nelle prime ore successive a questi eventi scatti e clip sui quali appunto non si smette d’interrogarsi. Proprio sulle stesse piattaforme in cui, a pochi clic di distanza, altri account pubblicano stomachevoli manifestazioni di giubilo per l’ultima carneficina. Ciò che, pur essendo di una chiarezza cristallina, tanto chiaro non appare è il concetto per il quale sono gli utenti a plasmare il modo in cui i social media sono utilizzati e si evolvono, e non il contrario. I social media sono più che comunicazione: sono anche un posto in cui viviamo: hanno certamente le loro peculiarità, ma allo stesso modo della ‘vita di ufficio’ in contrapposizione alla ‘vita privata’: non diremmo mai che la prima non è ‘vita vera’. Pertanto, anche se ci sono delle differenze, dovremmo smettere di pensare che l’online sia meno vero che l’offline. Stiamo vivendo la storia, una storia in cui la guerra si combatte sulla Rete prima che sulla strada. E questo lo ha sottolineato nientemeno che l’esercito britannico, creatore di un’unità speciale per quella che lo Stato Maggiore britannico ha definito come “Guerra Non Letale”. Una guerra che non si svolge sul campo di battaglia, ma sui social network. La 77esima brigata sarà formata da 1500 uomini esperti in operazioni psicologiche che verranno sviluppate utilizzando proprio i social network per minare la resistenza del nemico. In Inghilterra i soldati della brigata sono già stati ribattezzati, non senza nascondere un pizzico d’ironia, Facebook Warriors. Curiosamente, la nuova forza dell’esercito inglese eredita il numero di brigata che è appartenuto a un gruppo di combattenti che ha fatto la storia della Seconda Guerra Mondiale: i Chindits che affrontarono i giapponesi sull’isola di Burma. Minori in numero rispetto agli avversari nipponici, svilupparono una tattica volta a creare insicurezza e a colpire il morale del nemico con continui attacchi in puro stile guerriglia. Un po’ quello che ci si aspetta dall’unità recentemente creata, in una guerra condotta a colpi di tweet e post pubblicati sui profili Facebook, con tanto di foto. Anche se può sembrare un’idea bizzarra, i social network vengono già usati con scopi bellici, ancor prima che venisse creata un’unità dedicata allo scopo.